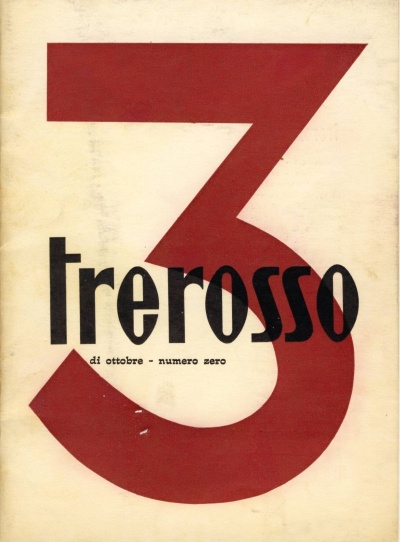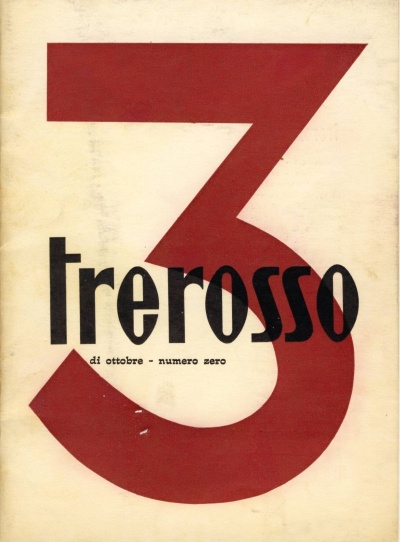|
1966: GLI ARRABBIATI DELLA CULTURA GENOVESE
di Claudio Tempo e Rodolfo Vitone
POETI ALL’ESTERO, IMPIEGATI IN PATRIA
Paragonati a quelli che hanno messo a rumore intere società costituite, a quelli che hanno fatto tremare le istituzioni culturali la cui efficienza addirittura aveva assunto le sfumature dell’intoccabilità, a quelli che al di là della Manica hanno saputo introdurre un tarlo fastidioso nelle coscienze pur placidamente riposanti nell’ovatta tutelare di un conformismo a sua volta conformato dalla funzionalità effettiva di enti, di strutture, di seguaci; a tutti quelli insomma che con il nome di “arrabbiati”, recenti e meno, si sono catapultati in una situazione storica e morale e l’hanno – fors’anche sottolineando la suggestione teatrale del gesto – presa per la barba ed i capelli; paragonati a costoro i giovani che a Genova tentano di fare qualcosa “di diverso”, di opporsi in qualche modo al cristallizzarsi – indiscutibile – della cultura dell’ufficialità, sembrano “tremare” sotto il peso (storico ed affettivo) di una simile qualifica.
Ogni epoca, ogni società, così come ogni città, ha avuto i “suoi arrabbiati”, meglio ha avuto gli “arrabbiati” che le competevano. Perché – si noti bene – se una comunità non ha “arrabbiati” non vuol dire che le cose vanno in modo così universalmente accetto da non poterne avere, bensì che non se li merita. Questa inquietante specie della fauna culturale vive e prospera infatti laddove esiste il suo cibo primo (un gioco effettivo di interessi culturali) e il suo ambiente più
propizio (la speranza che la sua esistenza valga a qualcosa).
Perciò, se da un lato abbiamo ceduto alla suggestione di quel nome (ed alla fantastica visione di una Genova percossa ed attraversata dall’infuocato, pungente, pirotecnico vibrare di energie e falciata dal fischio di mille fruste) dall’altro abbiamo dovuto – con quanto male in cuore solo noi lo sappiamo – rapportarci alle cose come stanno in “casa nostra”, poco propizie per fare acclimatare la sullodata specie culturale. Perciò “arrabbiati della cultura genovese” e non “arrabbiati genovesi della cultura”.
Scuote i baffi, “tirati” con la rabbia di un pettine fittissimo in un segno ben arcuato, mette a fuoco con un leggero tremito del naso gli spessi occhiali montati in tartaruga, quindi esordisce: “Cultura a Genova?” Sembra interdetto. Riprende: “Cultura a Genova? Sarò franco. Esiste la scuola, e tutti sanno com’è. Poi queste poche fonti d’informazione: “Marcatrè” (che anche se da Genova se n’è dovuto andare, resta pur sempre un “fatto” nostro), “Ana etcetera”, “Tool”, “3 rosso”, la Carabaga e il Deposito. Al di là di queste riviste e di questi “centri”, non c’é niente di niente, in fatto di cultura”.
Chi parla è Lino Matti. Si qualifica poeta e scrittore, raccomandando di tenere uniti i due termini perché staccarli tradirebbe la sua “natura” letteraria. Pezze d’appoggio in profusione: fondatore (con altri giovani “arrabbiati” genovesi) de “Il Marcatrè”, redattore di “Tool”, libri di poesia all’attivo, vincitore del premio “Flora” a Milano, Lino Matti è uno dei cinque poeti italiani d’oggi tradotti nell’URSS sulla rivista letteraria ufficiale moscovita “Inostrannaia Literatura” (ossia “Letteratura Straniera”), collaboratore di numerose riviste letterarie in tutto il mondo (ed in Brasile, alcuni anni fa, un suo scritto ha fatto sequestrare – con tutte le conseguenti “grane” del caso – una pubblicazione). Ma per vivere fa l’impiegato.
“È meglio dire – precisa – che faccio l’impiegato per vivere a Genova. E non sono il solo a tradire, per la pagnotta, il mestiere dello scrivere. A Genova vivono sei persone degne di essere annoverate fra le forze vive della letteratura contemporanea: un ormeggiatore, due rappresentanti di commercio, un disoccupato (ex manovale della Bruzzo), un impiegato ed un traduttore di gialli”.
La pausa che segue a questa “rivelazione” è carica di uno sguardo che meglio di ogni ulteriore parola serve da commento. Lo lasciamo immaginare. “E’ il solito ritornello – aggiunge Lino Matti – bisognerebbe espatriare, andare altrove. Ma io non approvo le fughe. Sono le opere che devono espatriare, non chi le fa!” Avvertiamo in quest’affermazione un’orgogliosa accettazione del martirio culturale che qui da noi, a Genova, passa sotto silenzio, nella maggior indifferenza possibile. È Lino Matti stesso che ce lo dice: “in determinati posti di lavoro dove la nostra opera potrebbe essere più qualificata (ormai tutti gli scrittori d’avanguardia si occupano di grafica n.d.r.) perché aderente all’evoluzione dei tempi, si trovano invece persone che vi si dedicano soltanto per caso, senza preparazione specifica e per di più completamente disinformati. Ma a Genova sono persone di questo genere che “vanno bene”. Non ci resta che sperare e contare su quei pochi veicoli di cultura ai quali ho fatto cenno”.
Veicoli di cultura innanzi tutto sono le riviste, perché dove vivono riviste vi è attenzione ai fatti culturali. E a Genova di riviste ne sono nate (e morte) tante. Vissute, molto meno. Alcune di esse – ed è il caso de “Il Marcatrè” – per sopravvivere hanno dovuto cercare “ossigeno” altrove. Oggi “Il Marcatrè” è forse la più importante rivista di cultura contemporanea europea (uno specifico premio internazionale lo comprova). Nacque perché in gruppo di giovani – che avevano in odio l’immobilismo genovese – volle che nascesse.
La loro iniziativa fu confortata dalle forze più in vista di tutt’Italia. Genova si affacciava per la prima volta alla cultura “viva” nazionale. Una quarantina di giornali e di riviste italiane e straniere esclamavano: “Finalmente Genova!”
Per qualcuno sembrava un sogno. Ed il bello è che un sogno, in effetti, era. Dopo 5 numeri l’ipertrofica (benedetta!) ingordigia “culturale” milanese l’aveva fatta sua.
“Genova, ancora una volta!” c’era da esclamare. Quei giovani ci rimasero male (ed è dir poco). Lino Matti (ed altri) non si diedero per vinti. Riprovarono – su un piano meno clamoroso, anch’esso con ampi riflessi nazionali e internazionali – e diedero vita a “Tool”, quaderni di scrittura simbiotica (unione del significato delle parole con l’immagine grafica delle parole).
“Perché “Tool”?”
“Perché “Tool” in inglese è un termine ben preciso che indica uno strumento nato per fare qualcosa di manuale, uno scalpello, un cacciavite, ad esempio. Insomma, uno strumento nel senso più pieno e diretto. In italiano non esiste un termine altrettanto preciso ed altrettanto vivo”.
Sulle pagine di “Tool” Lino Matti ed altri realizzano le loro idee di “isolati” letterati genovesi. Di quegli strani “giocolieri” delle parole che partecipano a movimenti che la cultura ufficiale genovese trascura. “Io cerco attraverso la tecnica del 'collage' o attraverso l’uso delle lettere in plastica, oppure in altro modo ancora, secondo le esigenze, di trasmettere idee in modo essenziale. Ossia voglio creare un linguaggio “letterario” che venga recepito in modo immediato, più direttamente di quanto avviene con la lettura pura e semplice. Da qui l’inserimento anche di segni grafici in un contesto verbale”.
“La mia è una posizione analoga – dice Ugo Carrega – ma non identica. Prima ancora di trasmettere dati emotivi, è necessario che si ricostruisca un linguaggio poetico. Quello tradizionale ormai è liso e senza possibilità di rendersi “espressivo”. È necessario cioè studiare come si struttura e come può diventare comunicativo un linguaggio. Partendo, infatti, dall’idea che se uno ha qualcosa da dire deve possedere un mezzo per dirlo, constatato che il linguaggio poetico tradizionale non permette di dire più nulla di attuale, bisogna rifarsi agli elementi che possono rendere “vivo”, oggi, un linguaggio (dal manifesto pubblicitario al rotocalco; dalla poesia in senso tradizionale ai vari tipi di segni che figurano sulla carta (spazi, parole, figure ecc.). Fatto questo, si troveranno con maggiore precisione le cose da dire, i “temi” da trattare”.
Anch’egli fondatore di “Tool”, Carrega è un nome forse sconosciuto alla cultura ufficiale genovese, ma da alcuni considerato di primo piano nella letteratura contemporanea italiana. Le sue “operazioni” di linguaggio sono state raccolte da riviste di portata decisamente internazionale: “Antipiùgiù” (Torino), “Die Sonde” (Colonia), “Marcatrè” (Milano), “Chelsea Review” (New York), “Phantomas” (Bruxelles) ecc..
Sta lavorando a due opere, “Il culto della gioia e del ritmo” (“operazione” di connessione tra elementi grafici ed elementi verbali) e “Rapporto fra il poeta e il suo lavoro” (poema continuo dove vengono raccolte le varie fasi di evoluzione delle sue ricerche).
Anche a lui chiediamo che cosa pensa della cultura a Genova: “La cultura a Genova è sempre stata indietro dai trenta ai cinquant’anni. Per rimuovere questa situazione è necessario rimuovere una mentalità. Per questa ragione è fondamentale che funzioni una forza 'ufficiale', politica.
Siamo in fase di elezioni: se al comune andasse un assessore “aperto” sarebbe possibile fare qualcosa. Altrimenti, per vie private, sempre e dovunque ci si troverà a cozzare contro una schiera di istituzioni che non si rimuovono neppure con la dinamite. E questo è il clima della provincia”.
Accenniamo al trito concetto del mercantilismo genovese: “Vorrei dire “ottuso mercantilismo”. Perché in Genova non esiste neppure la capacità di capire che l’editoria è un fattore economico. Perciò non esistono editori e perciò gli scrittori se ne debbono andare o fare dell’altro. Bisognerebbe che la mentalità mercantile venisse impiegata. Allora ci sarebbe la possibilità di creare anche delle possibilità di cultura.
Quando Ezra Pound faceva in Inghilterra la “Little Review” ha detto che il 50 per cento del materiale pubblicato era scadente, ma ciò rendeva possibile (poiché la pubblicazione 'andava') la stampa dell’altro 50 per cento, di valore. Del resto, chi non sa che dietro a collane “impegnatissime” ci sono vari rotocalchi e fumetti di terz’ordine?” All’ultima domanda Carrega risponde: “Per vivere traduco libri gialli, di guerra e di fantascienza”.
Perché “3 rosso” (che poi è verde) ha questo nome?
Perché – e a questo punto par proprio di entrare in quell’atmosfera “arrabbiata” che “sognavamo” – la rivista è nata in un “forno” per ceramica sito appunto al civico 3 rosso di una stradina di Sampierdarena. Luigi Tola, uno dei redattori si è interessato di un’infinità di “fatti culturali”. Nel 1949 – era giovanissimo – partecipava alla rivista “Il Portico”, nata a Pegli e – naturalmente – defunta. Quella rivista diffuse per prima in Italia poeti come Dylan Thomas e Paul Eluard. Ha collaborato con decine di altre pubblicazioni, ha scritto migliaia di “didascalie” per mostre contro la guerra, ha partecipato come autore di “poesia visiva” a mostre in mezza Italia e all’estero (da Parigi a Praga), è stato uno dei fondatori di quella singolare esperienza della “Cooperativa cinematografica spettatori e produttori” che ha realizzato il film “Achtung. Banditi!” e tanto altro ancora. Ora si dedica alla poesia “cinetica”, “evidente” e “visiva”. E ad una complessa “forma” di critica d’arte.
Gli chiediamo un’opinione sulla cultura a Genova: “il “Marcatrè” ha dovuto andarsene; “3 rosso” è appoggiato a Roma; “Nuova Corrente” è andata a Firenze; “Ana etcetera” è conosciuta ... in Inghilterra”.
Anche Tola riprende il tema della difficoltà che incontra un intellettuale a lavorare a Genova: “Ci si trova di fronte ad un vero e proprio rifiuto mercantile del nuovo. Per essere riconosciuti bisogna diventare 'grossi nomi'. E per diventare grossi nomi bisogna andarsene. Eppure, perché qualche cosa cambi è necessario fermarsi.” Dedalico dilemma. Il “3 rosso” si propone di divulgare le sperimentazioni culturali d’avanguardia. Tola, da parte sua, mira a usare il linguaggio di tutti i giorni (dei giornali, della pubblicità, del fumetto e così via) e l’elabora in modo da dargli un significato nuovo.
Quanto alla sua “critica d’arte” egli ci ha detto che “il quadro mi interessa in quanto può diventare argomento di un discorso. Ovvero ciò che interessa è il discorso sul quadro”.
Lasciamo il buio e disordinatissimo “forno” del “3 rosso” e dispieghiamo le vele per altre “isole” culturali genovesi, sperando che abbiano – come quelle incantate dei mari del sud – il loro bravo (ed attivissimo) vulcano.
(I - Il Corriere Mercantile, 9 giugno 1966)

UNO STAGNO E MOLTE IDEE
Ci abbiamo provato una decina di volte. Formato il numero telefonico di casa Oberto (Martino ed Anna), i due “arrabbiati” di turno nel nostro taccuino d’inchiesta, i responsabili e gli ideatori di “Ana etcetera”, una rivista che giuoca un ruolo particolarissimo nei fatti di cultura di oggi, la voce gentile ma fredda della pur efficientissima segretaria telefonica ci avvisava che i signori Oberto erano fuori casa.
Trenta secondi di tempo per registrare su nastro quanto desideravamo dire e poi tanti saluti. “Isolati” culturali va bene, ma gli Oberto sono addirittura irraggiungibili! Alla fine ci siamo decisi ad affrontare il vuoto ed assurdo di quei trenta secondi in cui ci si trova non poco buffi, costretti come si è a parlare ad una macchina: “Anna e Oberto carissimi, stiamo conducendo una piccola inchiesta sugli 'arrabbiati' della cultura genovese, ossia su quei giovani che intendono fare qualcosa di diverso da ciò che propone la cultura ufficiale genovese. Le nostre intenzioni sono così e così. Pertanto, visto e considerato che non possiamo concederci molte possibilità di raggiungervi di persona, affidiamo al magnetofono la speranza di ricevere il vostro pensiero in merito. Magari telefonicamente, magari per scritto o magari – se ci tenete – su nastro...”. Risponderanno?
Tre giorni dopo ci perveniva l’opinione dei coniugi Oberto. Tre fogli dattiloscritti, fitti fitti, da cui stralciamo quanto più da vicino ci interessa e, sperando di non travisare il loro pensiero, tenteremo di interpretare alcune frasi, decisamente importanti ma un poco “tecniche”.
“La situazione culturale genovese è, per “Ana etcetera”, costituzionale. Infatti se operassimo in un grosso centro culturale, A.E. non funzionerebbe come bollettino, o come rivista, che ha come scopo quello di stabilire contatti fra quanti sono interessati alle operazioni sperimentali a livello 'interlinguistico'. La necessità di pubblicare gli esercizi di A.E. si era determinata per la tipica chiusura locale di Genova. In questo modo è stato possibile aprire contatti in area 'planetaria' pur lavorando a Genova”.
Inizia a delinearsi il pensiero di due validi esponenti della “meta cultura”, ossia di quel complesso di interessi e di ricerche non già fatto in sede di dibattito culturale e di vita culturale attiva, ma staccato dal mondo dei fatti concreti della cultura per diventare esperimento “sulla cultura”, astratta valutazione, problematica strumentale, aristocraticamente isolata nel suo unico impegno filosofico, libero da ogni sollecitazione d’idea o d’interesse. Infatti leggiamo: “In termini culturali, Genova è la tipica città 'off limits', l’ombelico del mondo in sede filosofica. Siamo nell’occhio del tifone 'anaculturale'. Chi fa cultura e chi consuma cultura sta nei grandi mercati culturali delle metropoli, delle Università, ad Oxford, nei 'Villages', a St. Germain ... ma chi opera sulla cultura, chi progetta, chi 'pilota' sta a Genova”.
Dunque per Martino ed Anna Oberto il fatto che a Genova non si faccia né si consumi cultura è un dato positivo? In un certo senso sì: “Genova è una città seria, indifferente: vi sono più difficili le contraffazioni, la confusione culturale che il mercato si massa e la notizia 'teledivulgata' provocano è enorme, i mercanti ed i critici pagati dall’industria venduta al 'dio dollaro' creano il successo ed hanno bisogno di un mercato ricco ed idiota. I genovesi sono forse ricchi, ma non sono idioti. Semmai sono ignoranti e indifferenti. Il che non è poi un male perché la cultura che si può fare a Genova è fuori commercio perché nessuno compera cultura. A Genova la cultura è un hobby, qui l’uomo è 'ludens', la nostra città forza il braccio dell’avanguardia, quella autentica, quella dei dilettanti: un’avanguardia 'off' (ossia sciolta dalla suggestione e dalle esigenze di un mercato culturale)”.
Abbiamo poco sopra usato il termine “aristocrazia” per definire l’impressione che suscitano le idee e le intenzioni dei coniugi Oberto. Non è del tutto esatto (anche se non è del tutto errato): meglio è accettare il termine che essi stessi ci suggeriscono: “astrazione”. “Ana etcetera” configura uno
schematico modello di cultura essenzialmente ipotetico e utopistico. L’impresa è destinata all’anti-successo perché non è destinata ad un pubblico ma unicamente agli “operatori di cultura”. Si danno infatti notizie riguardanti i lavori che vengono compiuti nell’ambito di una analisi del linguaggio (così come la prospetta Silvio Ceccato), mirando a fare della filosofia sul linguaggio un’arte d’avanguardia.
Ossia una filosofia pensata come “ars”, una filosofia poetica. Tutto ciò in senso assolutamente astratto da ogni impegno in qualche modo politico. “Ana etcetera” ha raggiunto (nonostante la sua “inevitabile” circolazione privata) i maggiori centri di cultura del mondo ed è considerata un esempio unico nel genere.
Gli Oberto non sono gli unici, in Genova, a condurre una sorta di guerra al mercato culturale e perciò non si allarmano troppo per la deficienza della “vita culturale attiva”. Corrado D’Ottavi, collaboratore come poeta-scrittore-grafico di riviste nazionali ed internazionali, si definisce più semplicemente “un polemico”; ed esordisce: “A Genova non si può parlare di cultura: c’è semplicemente qualche attività di 'culturame'. Guarda un po’ che cosa sono a Genova le gallerie d’arte: botteghe equivalenti in tutto e per tutto a quelle del salumiere o del droghiere. La gente va lì e compera. Tutto si esaurisce in questo 'contatto'. Ci sono, è vero, la “Carabaga”, il “Deposito” e la “Polena”, che fanno qualcosa di diverso ma hanno limiti 'corporativi' e mercantili non indifferenti anche loro. La situazione è stagnante, senza aperture. Ma non tutto è negativo, in questo. Perché Genova ha il pregio di ... non avere i difetti delle situazioni non stagnanti, dove ogni idea viene bruciata in senso commerciale. Non sarà molto ma è già qualcosa”.
Ad onor del vero ci sembra che Corrado D’Ottavi abbia fatto suo il motto: “Chi si accontenta, gode” ed infatti aggiunge: “Genova è stagnante perché in questa città è così. È stagnante l’economia, alla quale manca ogni capacità evolutiva; è stagnante l’assetto urbanistico, completamente chiuso, diaframmato. Ed il discorso potrebbe continuare. È colpa delle iniziative che 'non si sono prese' negli ultimi vent’anni e che avrebbero potuto fare il miracolo anche di non costringere Genova ad essere una zona sottosviluppata della cultura con forte flusso emigratorio. Bastava che 'qualcuno' intervenisse a far sì che l’arte e la cultura potessero diventare fonte di guadagno. Ma, visto che non è stato così, si può gioire del fatto che qui nessuno è costretto a adeguarsi ad un mercato culturale, pena l’isolamento e ... la delusione economica”.
E, gioendo, Corrado D’Ottavi fa l’impiegato in una ditta di forniture navali. Nulla di male, certo, ma restiamo piuttosto scossi quando apprendiamo che Corrado D’Ottavi è stato il primo, in Italia, a studiare e attuare la 'poesia visiva', uno dei precursori di un orientamento poetico-grafico che oggi ha conquistato l’interesse generale. “Comunque io non ho mai avuto intenzione di 'vendere' le mie opere. E questo mi ha aiutato non poco a mantenere l’indipendenza interiore da ogni gruppo e da ogni sollecitazione. Cerco di condurre un’azione a carattere smitizzante, ossia nei miei 'quadri',
dove si affiancano parole, colori, segni grafici, elementi documentaristici (fotografie), cerco di 'svelare' le false illusioni, le suggestioni e la realtà di oggi. L’ultimo mio quadro riguarda “Africa addio”; e non è, la mia, una polemica leggera ...”.
Non crede nella possibilità attuale di scambi d’idee in sede cittadina ufficiale, dove la cultura “diventa museo e fatto di prestigio”; ma crede nei contatti privati: “Anzi, dite pure che sono disposto ad incontrarmi con chiunque fosse interessato a questo tipo di operazioni. Che mi telefonino a casa, quando vogliono. Fornirò tutte le spiegazioni che si vogliono”.
Concludiamo la parte della nostra inchiesta dedicata agli “arrabbiati” che si muovono nell’ambito della letteratura contemporanea e delle riviste rivolgendoci a un giovane studioso che a Genova non è rimasto, ma che ha partecipato (e continua a partecipare) a quei movimenti innovativi che
animano la vita culturale cittadina.
Germano Celant, componente del comitato direttivo della più recente rivista culturale genovese, “Modulo”, aveva partecipato alla creazione di “Marcatrè”, di cui tuttora fa parte. Il suo “carnet” ce lo indica come osservatore fisso delle mostre in Italia per la Biennale di Venezia, per “Casabella”, per “Grafis” (Parigi) come qualifica assume quella di critico d’arte. Ha in cantiere due studi di prossima pubblicazione (uno sul “Futurismo”, il secondo su “Pinin Farina”). A lui si deve il ciclo di conferenze sull’arte contemporanea che ha portato una ventata di attualità nell’ambito dell’Università.
Ci ha dichiarato: “Perché esistano delle forze culturali è necessario che vengano stimolate. Ora a Genova manca una produzione culturale proprio perché mancano le strutture atte a suscitarla. Il fatto che in una città come Milano gl’intellettuali siano “copy-righter” delle società pubblicitarie è chiaro indice di una mentalità lontanissima da quella genovese e perciò culturalmente feconda”. Ma il fatto più clamoroso è che a Genova non solo non si suscita una produzione culturale attuale ma si uccidono anche quelle che, per una ragione o per l’altra, riescono a nascere. Ed agl’infiniti esempi alcuni dei quali abbiamo riferito la scorsa settimana, va aggiunto quello del “Museo di Arte Contemporanea”. Ce ne parla Celant: “Il Professor Battisti era riuscito a costituire, con le donazioni degli stessi artisti, un cospicuo e valido patrimonio di opere contemporanee. Ebbene, Genova l’ha rifiutato. Tant’è vero che ora è stato interamente donato al Comune di Torino”. Che naturalmente
l’ha accettato di buon grado. Eppure, nei sette giorni durante i quali quel Museo funzionò, fu visitato da oltre mille persone, come ci testimonia Celant, che prosegue: “Insensibilità dunque delle 'autorità competenti'. Ma non solo. Infatti anche i librai non 'tengono' riviste d’arte contemporanea. Dicono che nessuno le chiede. Ma se nessuno le conosce, come fa a chiederle?” Il dilemma di sempre. Eppure vi sono prove evidenti che un interesse per i temi culturali di oggi sarebbe pur possibile suscitarlo. Il Museo di Arte Contemporanea che molto opportunamente si è rifugiato a Torino, lo dimostra. “I giovani, soprattutto, reagiscono positivamente e hanno sete d’informazione sui problemi attuali dell’arte e della cultura. Anzi vedo addirittura la possibilità di creare istituti che 'vivano' grazie ai giovani. Naturalmente è indispensabile che in sede 'ufficiale' ci s’interessi del problema. Dal basso possono derivare aiuti, ma il problema di una soluzione della 'crisi' culturale genovese deve essere risolto in sede di strutture 'ufficiali'. Ma se si pensa che neppure le biblioteche pubbliche si aggiornano, che c’è da sperare?”.
Da parte nostra non speriamo granché; ma Germano Celant – anche se per vivere dedicandosi completamente alla cultura ha dovuto fuggire da Genova come un lampo e trovare altrove (a Milano ed all’estero) i punti d’appoggio con cui collaborare – si mostra in fondo meno pessimista, sottolineando con soddisfazione il fatto che nella facoltà di Lettere della nostra Università è stata finalmente istituita una cattedra di arte contemporanea e rilevando come “Modulo” sia stato favorevolmente accolto fra i giovani: “Il male è – conclude – che a Genova esiste una struttura, legata a determinati posti di potere, infusa di pigrizia mentale e che rifiuta la dialettica. Genova insomma è una delle poche città ormai dove non si è ancora capito che il progresso della cultura significa progresso della città e che la cultura fa progredire la città”.
(II - Il Corriere Mercantile, 16 giugno 1966)

I NEMICI DEL SENSO COMUNE
Si può considerare un fatto veramente mirabolante se, dopo una serata di cultura “viva”, un dibattito dove esponenti “impegnati” di opposte tendenze d’avanguardia hanno espresso le loro opinioni, non si assista alla nascita di qualche “gruppo”, di qualche “team”, insomma di qualche manipolo di “operatori di cultura”, con il loro bravo manifesto in gestazione, pronti a “sbranare” il mondo degli oppositori e dei contrari. Può sorgere il dubbio che i dibattiti sull’attualità culturale molto spesso non abbiano come scopo quello di chiarire – reciprocamente – le idee ai contendenti, bensì quello di realizzare una sorta di selezione, il primo passo per la formazione di un “gruppo”.
Poi – spesso – succede che dopo aver esaurito la carica polemica “contro certe idee, contro certe posizioni”, carica che appunto rappresentava il tessuto connettivo del gruppo, i singoli partecipanti inizino a scoprirsi l’un l’altro, a guardare con occhio più critico “chi cammina a fianco”, a soppesare le idee individuali. Ed allora può accadere l’irreparabile: il gruppo come dalla polemica era nato così nella polemica si squaglia. Magari dando vita a sottogruppi, a loro volta arrabbiatissimi e bellicosissimi. E il ciclo – talvolta – continua.
Detto questo, si comprende facilmente perché il gruppo rappresenti il fenomeno più instabile della cultura d’oggi, ma anche il più tipico. Benché, naturalmente, siano assai più i gruppi defunti di quelli che resistono. Nella nostra piccola inchiesta locale abbiamo voluto ficcare il naso nel piccolo (o grande) universo integro di un gruppo “vivente” e in quello atomizzato di un gruppo “defunto”.
E fa ingresso nel nostro carnet l’arte figurativa (pardon, l’arte spazio-visiva).
Ci troviamo ancora una volta in quel tale forno di ceramiche di Sampierdarena che sembra essere l’approdo degli arrabbiati genovesi. Qui – e lo vedemmo – nacque il 3 rosso, qui si organizzano le serate de La Carabaga, il centro che da tutti gli arrabbiati che abbiamo interpellato ci è stato indicato come uno dei pochi centri di attività culturali genovesi; e qui depositano le loro “operazioni” gli undici componenti del “Gruppo Studio”. È fra ritagli di rotocalchi, pezzi di stoffa già impiastricciati di colla e pronti per l’uso, tavole di legno, stranissimi ingranaggi, fili variopinti e no, titoli ritagliati dai giornali, bambole orrendamente mutilate di teste, braccia e gambe, inquietanti manichini, vasetti che trasudano colori, tele raggrinzite di bitume, cornici desolatamente vuote e – chi l’avrebbe mai detto – spatole e pennelli; è fra tutto questo che ascoltiamo l’esaltante affermazione di Guido Ziveri, uno degli undici, il più “elettrizzato” di tutti: “il gruppo è la grande esperienza che non ci fa sentire soli, incomunicabili, è la grande esperienza che si sviluppa dal confronto continuo, dal dialogo e nell’indagine di più cervelli, da estrazioni culturali diverse, da diverse situazioni psicologiche”.
Ma oltre alla diversità esiste qualcosa di comune?”, chiediamo. Ziveri sembra non averci sentito e prosegue, ammirando soddisfatto l’emporio di distruzione che lo circonda: “Il gruppo è incominciare a vivere; è uscire dalle aporie del pensiero individualistico; il gruppo è consapevolezza critica; il gruppo è superamento delle strutture conservatrici; il gruppo siamo noi”.
Rifacciamo la domanda: “In nome di che cosa vi siete uniti?” Interviene Luigi Tola (del quale ci siamo già occupati nelle precedenti puntate e che ha posto la sua attività di scrittore al servizio del gruppo): “In senso molto generico noi tendiamo a sperimentare i nuovi linguaggi di espressione e di comunicazione. E il fine dello sperimentalismo è rovesciare i linguaggi antichi …” Probabilmente Tola vorrebbe aggiungere qualcosa ma ha di nuovo il sopravvento Ziveri che si incarica di proseguire con loquacità entusiasta, travolgente: “… e non solo i linguaggi in senso formale, ma ciò che essi rappresentano di più fossilizzato, il senso comune. Noi sentiamo in modo particolare l’esigenza di andare oltre il senso comune. Perciò io non faccio “quadri” ma “quasi quadri” e così via. È proprio il senso comune – che ci fa bere Coca Cola, andare in auto nel traffico impossibile e televedere il signor Buongiorno - il nemico da battere su tutti i fronti. Lui, il senso comune, è talmente abile da mandare a destra la sinistra, la destra al centro e il centro a sinistra, da confondere le cose al punto di far sentire liberi gli integrati, eterodirigere le masse, ridurre le ideologie al possesso della merce. E gira e gira e gira, certo che a forza di girare qualcosa gira; noi cerchiamo di far girare il girabile e di capire perché il non girabile non gira; e cerchiamo di capire per far girare anche il non girabile. Capito?”
Rileggeremo gli appunti. Certo è che i suoi compagni d’azione, gli altri dieci del “Gruppo Studio” lo capiscono benissimo. Chi sono? Sono tre pittrici, tre pittori (di cui uno, Ziveri, anche ceramista e gli altri grafici), un critico, un fotografo e cineoperatore sperimentale, due scultori. È proprio uno degli scultori a ritornare sul “senso comune” descrivendoci le sue operazioni. Maurizio Guala, venticinquenne di mestiere odontotecnico, come artista è decisissimo sostenitore del non senso: “Io faccio delle macchine che non sono macchine; degli strumenti che non sono strumenti. Sia le mie macchine<, sia i miei strumenti ricordano quelli che funzionano sul serio. Ci sono ruote, ingranaggi, fili, manovelle e così via. Ma se li metti in moto non funziona proprio niente. In questo modo voglio da un lato deludere quelli che ancora considerano la scultura come un fenomeno da museo, da olimpo, da altare e dire invece loro: niente soggezione! Non vedete? Con la scultura si può giocare. Dall’altro però intendo anche rispecchiare lo spirito della nostra società. Ci troviamo in una perenne ansia di attesa, ma poi non succede mai nulla. Così è con la mia scultura: sembra una macchina, ci si attende qualcosa, e invece non succede proprio niente”.
Luigi Tola chiarisce ulteriormente il discorso di Guala con un’immagine: “Le sue opere, come quelle di alcuni altri del gruppo sono come dei biliardi senza sponde…”
Se non andiamo errati è questo il senso della “demitizzazione” che il gruppo ha assunto a sua bandiera. Ci interessa a questo proposito il discorso che nel frattempo ha iniziato Olga Casa, pittrice, che racconta: “Ho conosciuto molte persone che, a detta di tutti e soprattutto di loro stessi, avevano ispirazione, talento, sensibilità, intuizione, folgorazione. Dapprima queste categorie verbali mi hanno veramente intimidito, poi ho capito che non hanno nessun significato, ma che la gente le accetta così, come legge i rotocalchi, come segue la moda, come crede nella libertà. Ma allora – mi sono detta - anch’io posso essere un «genio»! E immediatamente ho fatto mostre, ho vito premi internazionali, ho avuto critici che parlavano di me, riviste che pubblicavano foto dei miei capolavori. Poi ho conosciuto altri «geni» che come me al «genio» non credevano. Facciamo un gruppo? E abbiamo fatto il «Gruppo Studio» che perciò è un collettivo che cerca di dire, a quelli che nel genio credono, che il genio non esiste e che la folgorazione, l’intuizione, l’ispirazione sono soltanto parole di comodo per poter dire che esiste la vocazione dell’artista e del miliardario, la vocazione del generale e quella del bracciante. Un comodo tutto calcolato per lasciare le cose come stanno, per continuare a bere Coca Cola, vestire Chanel, guardare la TV essere incondizionatamente per la virtù che come tale sta sempre nel mezzo. E andare alla Biennale, e avere il mercante che ti compra tutto per una miseria mentre lui fa i miliardi perché ha la vocazione e così via …” Tutti gli undici componenti del gruppo assentono.
Della cultura a Genova, questi arrabbiati, che ne pensano? Roberto Villa, fotografo: “Il fatto che non esistano enti culturali non è già di per se stesso dimostrativo?” Olga Casa: “Ce n’è tanta, ma con l’ispirazione …” Guido Ziveri: “Ma certo che ce n’è! Il Deposito, isola culturale dell’est; La Carabaga, isola culturale dell’ovest. Al centro? Centro sinistra”. Tutti gli altri assentono e noi ce ne andiamo.
Ci attendono quelli che avevano dato vita ad un noto gruppo d’avanguardia genovese, Tempo 3, sciolto dopo due anni, dopo aver partecipato alle maggiori manifestazioni artistiche italiane e aver sognato di veder Genova svegliarsi. Ma il sonno culturale è continuato e allora le armi con cui, unendosi, i quattro avevano predisposto per partecipare alla rinascita della Superba sono divenute inutili. E allora ciascuno è andato per la sua strada.
Così almeno ci sembra abbia voluto farci intendere Giancarlo Bargoni di Tempo 3 con profonda amarezza. Per lui e alcuni suoi compagni di lavoro pare essere stata una triste esperienza. Una di quelle esperienze che fanno conoscere meglio il mondo ma che lasciano tracce difficilmente cancellabili: “Ci siamo riuniti, Attilio Carreri, Arnaldo Esposto, Gianni Stirone, il fiorentino Riccardo Guarneri ed io, verso la fine del ’63 quando sembrava che la situazione culturale genovese si stesse scuotendo da quel torpore che la caratterizza”.
Ma, invece, Genova li addormentò; e così sorsero alcune incomprensioni, un po’di scoraggiamento che fece “risaltare la congenita pigrizia dei componenti del gruppo” e questo si sfasciò. “A Genova non esiste niente, o ben poco. È inevitabile che unno si chiuda in se stesso, magari dopo una esaltante fiammata da «arrabbiato» e mediti sul suo lavoro e stop. Io rifletto sulle varie possibilità che il colore ha in rapporto alla complementarietà e con certe zone, organizzate simmetricamente, sia in rilievo che colorate, cromoplastiche”. Bargoni sembra aver concluso.
Ancora più sintetico si mostra Gianni Stirone. Del gruppo non parla e si limita a dirci: “Per quei lettori ai quali il senso di termini come «cultura ufficiale cittadina» sono familiari e chiari, parafrasando dirò che ogni città merita essenzialmente la cultura ufficiale che ha. E, per conservare alle risposte un manicheistico simulacro di chiarezza, dirò che con i miei lavori mi prefiggo perlomeno di non essere chiaro, familiare ecc. …”. Detto questo, ci ringrazia e scompare nel dedalo dei vicoli del centro storico.
L’ultimo dell’ex Tempo 3 che avviciniamo è Attilio Carreri, uno degli artisti più singolari che abbiano operato a Genova. Sin dal 1955 ha sperimentato tecniche pittoriche di estrema avanguardia (per Genova addirittura fantascientifiche) e che oggi rappresentano un filone universalmente accettato. Etichettando si potrebbe parlare di informel, ma Carreri non ama le etichette.
Da sott i baffi duramente travagliati dal fumo del sigaro, ci dice: “Genova non ha ancora il volto di un grande centro culturale, ma credo che ne avrebbe tutte le possibilità, soprattutto per il fervore di ricerca che anima i giovani. Direi anzi che mai come oggi si annuncino buone prospettive …”.
Sebbene già si avvii alla cinquantina (ed è l’unico artista maturo da noi interpellato) Carreri si sente giovane come non mai e perciò vicinissimo ai giovani. Ai quali propone le sue ricerche come valido terreno di dibattito costruttivo. In che consistono? “La pittura come mezzo che permetta una ricerca nel movimento strutturale della coscienza, La base di queste strutture è il tempo, il susseguirsi continuo. Una coscienza che guarda se stessa, non i fenomeni che produce. Ma essa stessa fatta fenomeno. Scansione, ritmo, variazione continua di spazi. Una pittura architettonica, una pittura musicale”.
Dunque, fiducia nei giovani e materia da meditare.
(III - Il Corriere Mercantile, 23 giugno 1966)

UNA CASA INTORNO ALL’UOMO
Ci siamo sorpresi ad osservare alquanto stupiti la fotografia di uno strano plastico. Che avesse qualcosa a che fare con un complesso unitario di elementi destinati alla abitazione, non v’era dubbio. Tanto più che ci si trovava nello studio di tre ingegneri che si sono uniti e pertanto hanno dato vita a un gruppo di progettazione edile. Ma quel plastico, spoglio di ogni compiacimento nel dettaglio, scabro e duro nella sua delineazione sommaria, con un senso tutto particolare di aderenza al terreno segnato a terrazze, concepito esso stesso – l’edificio – quasi come terreno, anticipava l’impressione che ci saremmo incontrati con persone – i progettisti – dalle idee alquanto particolari.
In fondo ci eravamo rivolti a questi tre giovanissimi esponenti dell’architettura genovese appunto perché contavamo che avessero da dire qualcosa che poteva tornarci utile per concludere la nostra sommaria panoramica su quelli che a Genova operano ed agiscono per smuovere le acque, per vincere l’ovatta e la sonnolenza che gravano sul mondo culturale locale. Ed il nostro incontro con due de tre componenti dello studio di architettura e di ingegneria civile C.L.M. (Corsanego, Lagomaggiore, Morselli) è iniziato con la “lettura” del plastico in questione.
“Si tratta di un insediamento per vacanze che avevamo studiato per Finale Ligure – ci dicono Filippo Lagomaggiore e Filiberto Morselli – e appunto, quello che vedete, è un’indicazione riguardante il nocciolo delle nostre ricerche: dare vita ad uno spazio attrezzato per virtualità abitative”, Francamente ci siamo sentiti un po’ spersi.
Ed ecco che allora viene, stimolante e – ci sembra – interessante, una spiegazione ad uso di chi, come noi, di queste cose ha in fondo soltanto un’infarinatura. “Innanzitutto abbiamo scartato la soluzione basata sui villini distribuiti a macchia d’olio in quanto avrebbe avuto come conseguenza la radicale manomissione del terreno ad uliveto, ridotto ad una serie di sistemazioni a verde privato, di carattere suburbano. Invece la soluzione dell’accentramento dei nuclei edilizi in un complesso condominiale permetteva di salvaguardare un’ampia zona di verde naturale e di creare un filtro ai rumori e quindi uno stato di quiete e di silenzio”.
A questa introduzione fa seguito una particolareggiata e profonda indagine sul significato della casa per le vacanze, che, per sua natura, delle fondamentali funzioni dell’uomo (abitare, lavorare, coltivare il corpo e lo spirito, circolare) non deve tener conto della seconda (lavorare) mentre deve stabilire una strettissima relazione fra la prima e la terza (abitare e coltivare il corpo e lo spirito), il che si realizza unicamente con l’efficiente soluzione della quarta.
Nel corso dell’esposizione avvertiamo che quanto agita il pensiero e il lavoro di questi giovanissimi progettisti è il senso vivo dei fondamenti funzionali delle loro opere. Il metro «uomo» trova nei loro discorsi una valutazione particolare, sul piano psicologico, emotivo ed esistenziale. Alle spalle di una strada pedonale, o in galleria, o di una scala a chiocciola invece che a scaglioni esiste un’indagine meticolosissima di un complesso di fattori culturali che restituiscono a colui che usufruirà di quella strada o di quella scala il dominio dell’opera architettonica.
Ed a riprova di questa osservazione giunge l’ultima parte della spiegazione del plastico che ci aveva – giustamente – interessato: “Come prassi, quando si progetta un edificio, si tiene conto delle esigenze di chi in ipotesi lo occuperà, ma non si offre alcuna possibilità a colui che effettivamente lo abiterà di intervenire nella sistemazione della sua abitazione. L’utente si trova di fronte un organismo rigido e precostituito; a lui sta accettarlo così com’è oppure rifiutarlo. Nel nostro progetto voi invece abbiamo voluto offrirgli la possibilità di intervenire nella disposizione e nell’utilizzo dell’abitazione. Cioè, non abbiamo fissato gli interni del complesso. Abbiamo individuato una “cellula” generatrice, con lati di 4 metri e 40. Quindi abbiamo delimitato l’espansione in profondità e in senso orizzontale della successione delle cellule. Ma il loro disporsi e giocare per dare vita ad abitazioni circoscritte e del tutto libero. Ne discende uno spazio architettonico informale che possiede una virtualità di utilizzazioni enorme: migliaia di possibilità. La suddivisione interna dell’edificio sarà effettuata in base ai gusti di chi lo abiterà, in modo che le cos prenderanno forma attorno agli utenti, generate dalle funzioni che essi intendono svolgervi”.
Chiediamo se tale soluzione sia una novità assoluta: no, non la è. Semplicemente si tratta di uno dei vari orientamenti d’avanguardia che, già ampiamente applicati all’estero, hanno trovato in Italia probanti applicazione, ma a Genova ed in genere nel mondo ligure appaiono assurdità, frutto di menti esaltate o giù di lì. Perché come su ogni problema della cultura d’avanguardia, anche sull’architettura esiste qui da noi il più sconfortante assenteismo. Anche quando – come in modo evidente si può dedurre dal problema dell’architettura – le innovazioni sono determinate dal preciso intento di dare una risposta ad esigenze concrete dell’uomo d’oggi. Nonostante questo, la vecchia strada resta non tanto la preferita quanto l’unica.
Il che si riflette non solo sull’aspetto architettonico esteriore della città – il che è ovvio – ma anche sul clima in cui si trovano ad operare gli architetti a Genova: “Gli architetti genovesi non si sono mai riuniti per esaminare i problemi d’attualità dell’architettura, vivono e agiscono isolati, non hanno neppure l’abitudine, in genere, di frequentare congressi, il che significa che non sentono la necessità di aggiornarsi. Ed anche quei pochi che fanno cose veramente pregevoli, sono inglobato in questa situazione d’isolamento: le loro opere passano inosservate, le riviste specializzate nella maggior parte dei casi se ne disinteressano. E così quelle forze vive che potrebbero portare un contributo concreto per risolvere anche molti dei gravi problemi architettonici e urbanistici della nostra città sono assimilate ai tanti che, invece, alla resa dei conti, non fanno che peggiorarli”. E così, ci sembra di aver capito, anche se a Genova si fanno tante case nuove, la città inesorabilmente invecchia. E i suoi problemi si aggravano, soprattutto sotto l’aspetto urbanistico, dove le idee coraggiose vengono inesorabilmente bocciate (quando, naturalmente, abbiano la possibilità di farsi avanti, il che non sempre avviene), magari lasciando la sensazione che l loro fallimento abbia contribuito più che una valutazione del loro significato, una incompatibilità di carattere tra chi le ha concepite e chi le doveva approvare.
Tutti, riteniamo, sanno che una città moderna deve essere “urbanisticamente” moderna; che una città dinamica non può non essere anche architettonicamente dinamica. Perché non v’è dubbio che l’aspetto esteriore di una città riflette la psicologia dei suoi abitanti, per lo meno quella di coloro che più degli altri ne hanno in mano le sorti. “Una città viva culturalmente presenta questo carattere anche attraverso la sua sistemazione urbanistica e la sua veste architettonica. Perché i tempi nuovi propongono problemi psicologici, metri di valutazione, interessi ed esigenze nuove, da cui né l’urbanistica né la funzionalità architettonica possono prescindere. Un tempo il problema didattico si appoggiava sulla capacità dell’insegnante di inculcare nozioni e concetti al fanciullo. Oggi invece prende le mosse da un rispetto più profondo per la sua personalità e ci si chiede: «come apprende, il fanciullo?». Perciò se prima bastavano dei locali dove un insegnante distribuiva il sapere, oggi si deUna città aperta sente l’esigenza di soluzioni aperte in ogni settore. Aiuta, non respinge, chi propone idee nuove; sollecita, non soffoca, l’informazione sui temi di attualità; si guarda attorno, non si isola”. Su queste parole di Filippo Lagomaggiore e di Filiberto Morselli (evidentemente condivise anche dal terzo del gruppo, Alfredo Corsanego) si chiudono le nostre interviste.
Lo avevamo premesso: gli «arrabbiati» di Genova non possono competere pe spregiudicatezza e aggressività con quelli veri, che ben hanno meritato questo appellativo in altri contesti ambientali. Con quelli che altrove hanno messo a rumore le coscienze e hanno inferto colpi irrimediabili a una situazione ambientale statica e l’hanno costretta al dinamismo. Tanto è vero che i nostri «arrabbiati», ben lungi dal portare lo scompiglio, di fronte all’imperante «compostezza» del clima genovese quasi quasi si ritirano in un cantuccio e magari accettano di fare delle loro aspirazioni innovative il fulcro dei dopocena, adattandosi per campare a lavori impiegatizi dei più normali e anodini.
Qualcuno, molti anzi, hanno lasciato questa città che non vuole ascoltarli, che non sa cosa farsene delle loro idee (che sono poi, nella maggior parte dei casi, semplicemente attuali, non certo peregrine, se si volessero superare i confini della città). E altrove si sono inseriti autorevolmente nel dibattito e nell’operosità culturale dei nostri giorni. Ma non sapremmo dire se siano costoro, i più coraggiosi, o quelli che, nonostante tutto, hanno scelto di restare «in patria». Magari subendo l’umiliazione di vedere le loro proteste culturali avvilite al rango del più scontato mugugno di strada, al quale l’ufficialità, sicura del generale appoggio che la sorregge, volta le spalle con quella sufficienza che ha reso tipica, proverbiale addirittura, Genova agli occhi del mondo culturale italiano.
Li abbiamo sentiti parlare, abbiamo raccolto (in parte) le loro considerazioni sulla situazione culturale genovese. Moltissimi altri ancora avremmo potuto interpellare perché gli «arrabbiati della cultura genovese» non sono soltanto quelli che sono sfilati su queste colonne. Tra l’altro noi ci siamo interessati soltanto dei più giovani, nel cui animo l’amarezza non ha ancora raggiunto uno stadio di cronicità e di letalità tale da portarli ad affermare che non c’è più nulla da fare.
Anzi, per costoro, si può fare qualcosa. E noi vogliamo crederci anche se talora può apparire un’impresa disperata cambiare una mentalità avallata da una tradizione di prudenza e di «pruriti» che affonda le radici molto, ma molto lontano.
In fondo quel che hanno detto questi «arrabbiati» non ha l’impronta della scoperta, della novità. Che in Genova manchi ogni stimolo per il nuovo, che esista anzi un «rifiuto mercantile del nuovo», lo si sapeva da tempo. Che manchino le fonti d’informazione, che le librerie siano sprovviste delle riviste d’avanguardia, che le biblioteche pubbliche non si aggiornino, che la famosa mentalità mercantile dei genovesi abbia mostrato forti limiti nel non intuire che anche la cultura può dar vita ad attività utili e nello stesso tempo proficue per Genova, non sono certo fatti opinabili.
Più sorprendente è invece constatare che nonostante tutto ciò proprio nella nostra città sono venute idee e contributi (sfruttati altrove) alla civiltà culturale dei nostri giorni; che esistono, nonostante tutto, degli «arrabbiati»; che anzi non sono pochi, anche se isolati e misconosciuti. Ci siamo rigorosamente astenuti dal dare una valutazione di quanto in letteratura, pittura, scultura, grafica o architettura, essi facciano. Innanzi tutto, per noi era – ed è – importante dare atto che sono proprio loro, gli «arrabbiati», le vittime culturali di questa città, a dimostrare il più vivo sentimento e trasporto verso Genova. Perché sono loro a temere che Genova continui a restare chiusa, diventi una «città museo», si compiaccia di quella frattura che la divide da quel fervore di idee e di apporti che costituisce, lo si voglia o no, l’aspetto fondamentale dell’anima dei nostri giorni.
Genova, in nome del buon senso comune, ha sempre atteso venti, trent’anni prima di accettare le novità. Cioè ha atteso che diventassero fatti vecchi, scontati e pacificamente accettati. Recentemente ancora ha addirittura rifiutato il regalo di un museo d’arte contemporanea. Di quante iniziative sia stata la tomba, lo abbiamo sentito. E allora, se è il buon senso comune a fornirle certe tendenze letali, sia lode al Cielo che esiste qualcuno che, non foss’altro, al buon senso comune vuol tirare la barba.
(IV - Il Corriere Mercantile, 30 giugno 1966)
|