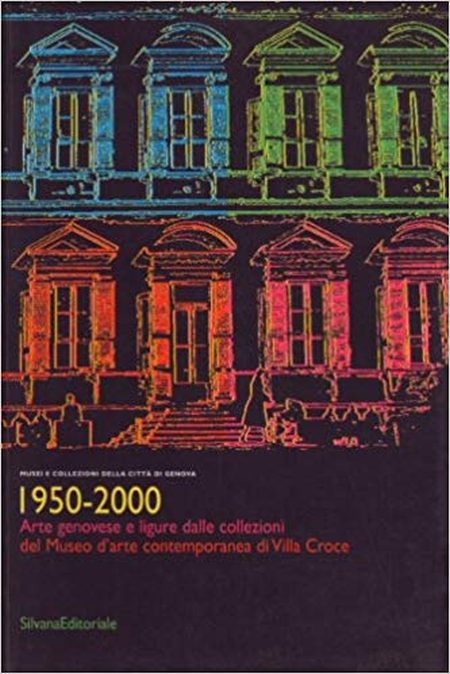|
2001: NUOVE MUSE, NUOVI BARBARI
1950-2000. Arte genovese e ligure nelle collezioni del Museo d’arte contemporanea di Villa Croce
di Guido Giubbini
Al momento della sua inaugurazione, nel febbraio 1985, il Museo d'arte contemporanea di Villa Croce non era ancora, a rigore, un museo, perché non possedeva un patrimonio di opere d'arte; ma, diversamente dai "musei senza patrimonio" teorizzati un po' demagogicamente dalla critica di quegli anni e sorti effettivamente qua e là in Italia con funzioni più che altro di showroom (e poi, tardivamente e per ragioni di facciata, dotate di un qualche patrimonio), era stato pensato soprattutto per svolgere un'attività di acquisizione permanente e quindi di conservazione attiva - essendo impensabile, per la mia formazione di storico dell'arte, prescindere dall'esperienza diretta dell'opera d'arte nella sua fisicità. e quindi dal dovere della sua fisica conservazione.
Non per nulla, con decisione simbolica, Villa Croce fu inaugurata con una mostra dedicata alla raccolta che Maria Cernuschi Ghiringhelli aveva diviso tra le sue case di Milano e di Arma di Taggia, raccolta che la collezionista milanese, dopo inutili e frustranti tentativi di legarla a qualche piccolo comune della Riviera
ligure di Ponente, sul modello della vicina Costa Azzurra, aveva offerto in acquisto al Comune di Genova, e che dopo essere rimasta in deposito al museo al termine della mostra fu comperata nel 1990 al prezzo di 750 milioni. Della collezione venne pubblicato un primo catalogo nel 1985 e un secondo, definitivo, al momento dell'acquisto (Milano, 1991).
Purtroppo quello della collezione Ghiringhelli fu l'unico tentativo di acquisizione, dei molti portati avanti tra il 1980 e il 1985, ad avere successo (e sia pure dopo traversie infinite, anche giudiziarie, che lo misero in forse sino all'ultimo). La mia intenzione era quella di porre fine, se non rimedio, all'emorragia di patrimoni di opere d'arte moderna e contemporanea da Genova e in genere dalla Liguria verso città culturalmente più attente e sensibili.
Nel 1969, quando entrai come funzionario nella Direzione dei musei genovesi, si erano da poco concluse le amare vicende delle collezioni dr Alberto Della Ragione e del Museo Sperimentale di Eugenio Battisti, finite rispettivamente a Firenze e a Torino, dove adesso sono esposte al pubblico in spazi comunali. Caterina Marcenaro, che da un quarto di secolo dirigeva i musei genovesi, era ostile all'arte moderna e contemporanea (anche se non, contraddittoriamente, all'architettura contemporanea). Fu necessario attendere le prime giunte dl sinistra e soprattutto i due assessorati consecutivi (1976-81 e 1981-85) di Attilio Sartori, intellettuaIe appassionato e di grande apertura mentale, non inquadrato nella logica dei partiti, perché il Comune di Genova tornasse a occuparsi di arte contemporanea. Sartori mi incaricò di organizzare e gestire uno spazio per mostre d'arie contemporanea - subito individuato nell'ex Teatro del Falcone di Palazzo Reale, ottenuto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali con affitto simbolico grazie alla disponibilità della Soprintendente Clara Palmas Devoti (dopo il 1955 il Falcone, per ragioni inspiegabili, fu abbandonato e restituito alla Soprintendenza, proprio nel momento in cui la concessione al Comune stava per diventare perpetua).
Tra 1a fine del 1978 e i primi anni Ottanta organizzai al Falcone mostre a cadenza mensile (il resoconto dei primi due anni 1o si ritrova in Genova: cultura di una politica, Firenze 1981), con finanziamenti pressoché nul1i e quindi con mezzi fantasiosi, metà delle quali dedicate a una sistematica ricognizione di quanto era stato fatto a Genova da1 dopoguerra, con il duplice scopo di aggiornare l'informazione e dl ricucire i rapporti tra l’istituzione e i vari soggetti del mondo dell'arte, in primo luogo gli artisti. In questo lavoro mi affiancavano un consulente, Francesco Vincitorio, che conoscevo dai tempi della rivista Notiziario d'arte contemporanea (NAC) e di cui ammiravo l'onestà e l’indipendenza intellettuale, e l'architetto Agostino Fronzoni, segnalatomi da Ezia Gavazza, per gli allestimenti e la grafica. All’inconfondibile, ascetico stile di Fronzoni (che dovetti difendere a spada tratta per anni tra lo sdegno generale) si deve la magnifica immagine coordinata dei cicli di iniziative annuali, non solo espositive, che andarono sotto il nome di "Arte e Città". con base al Falcone ma estese via via anche a Palazzo Bianco, al Rosso, alla Commenda e a altre sedi non comunali.
Fu evidente fin dall’inizio che il Falcone non poteva bastare e che comunque non poteva sostituire una vera struttura museale. Perciò cominciai quasi subito a cercare un edificio - un "contenitore" come si diceva allora - che potesse ospitare il nuovo museo. Sfumata, con mio grande rammarico, l’ipotesi di Villa Gruber, da poco acquisita al Comune, e poi in realtà, come spesso succede, malamente utilizzata, mi concentrai su Villa Croce. che non interessava a nessuno e che ben conoscevo perché nel 1974 vi avevo organizzato per Corrado Maltese il Convegno lnternazionaie di Studi su Galeazzo Alessi. Villa Croce era una bella casa ottocentesca collocata in magnifica posizione sul mare, all'interno di un giardino, e con una storia strana: donata nel 1951 alla città dalla famiglia Croce per farne un museo, era diventata negli anni Cinquanta e Sessanta luogo d'esilio per funzionari sgraditi (una forma di emarginazione drastica ma tutto sommato più civile del contemporaneo "mobbing"). Per qualche tempo, credo, furono parcheggiati nella Villa anche i depositi del Museo d'arte orientale Edoardo Chiossone, mentre gli ospiti di un altro Chiossone, l'lstituto per ciechi Davide Chiossone, vi tenevano un laboratorio dove confezionavano per I'ACI le targhe delle automobili. La manutenzione naturalmente era nulla, al punto che la rottura e la mancata sostituzione dei vetri degli abbaini provocò tra il 1974 e il 1980 disastrose infiltrazioni e crolli parziali delle volte.
Sartori, che era attentissimo al problema delle strutture per la cultura (nel corso del suo secondo mandato furono decisi quelli che sarebbero stati i principali interventi strutturali dei decenni successivi, dal Carlo Felice al Ducale) ma conosceva ovviamente meglio di me i retroscena della politica, mescolava entusiasmo e scetticismo (il suo poco incoraggiante ritornello era: "non ce la farai mai!"). Ma chi mi aiutò di più fu Franco Monteverde, allora assessore al bilancio, che stanziò i circa 500 milioni necessari al restauro e all'arredo dell'edificio. Mentre Ì lavori procedevano tra alti e bassi (iniziati nel 1980, furono poi sospesi per alcuni anni e ripresi nel 1983) feci una serie di tentativi per acquistare collezioni private. Nel 1980 fui contattato, tramite Gianfranco Bruno, dalla vedova Jesi, che nella sua casa di Sori presso Genova aveva una grande collezione di sculture e disegni di Marino Marini e molti bei dipinti (un Klee, parecchi Baumeister, un Wols strepitoso...).
La vedova Jesi proponeva al Comune una mostra di Marini (morto nell'agosto di quell'anno) in vista di una possibile donazione. La mostra fu realizzata a Palazzo Bianco nell'estate del 1981 con reciproca soddisfazione e nei mesi successivi fui spesso ospite della Jesi. La proprietà di Sori era davvero affascinante, in quanto mescolava l'architettura razionalista di Labò - una fantasia De Stijl - al paesaggio romantico dei grandi pini e della scogliera a picco sul mare; il tutto animato dalle sculture di Marini, in piedi o a cavallo, dalia silenziosa servitù, da una vigile dama di compagnia e dall'anziana signora, la cui rarefatta conversazione risentiva già della malattia che avrebbe poi vanificato il comune progetto. La casa, che come auspicava giustamente Giovanna Terminiello, avrebbe potuto e dovuto diventare, tra architettura, giardino, arredi e collezioni, uno straordinario museo, è stata recentemente svuotata e trasformata in un condominio.
Di tutt'altro tipo la proposta di Panza di Biumo di concedere in deposito parte delle sue raccolte di arte americana, concettuale e minimal. Visitai con emozione la casa di Panza presso Varese (passata pochi mesi orsono con le sue collezioni al FAI) insieme a Sartori, Monteverde e Ezia Gavazza. Con mio grande rammarico la cessione non poté avere luogo perché le imponenti installazioni degli artisti americani richiedevano uno spazio di almeno tremila metri quadrati (contro i millecinquecento di Villa Croce). È davvero esasperante che una città come Genova, con i suoi ettari di aree industriali dismesse, gli enormi palazzi semivuoti, i magazzini e le opere militari gigantesche, abbia avuto tanta difficoltà, nell'ultimo mezzo secolo, a dare un'adeguata sistemazione alle collezioni d'arte offerte dai privati e a maggior ragione alle proprie.
Mentre in questo e in altri casi il punto di partenza era una sostanziale intesa, nessun esito ebbe il tentativo di acquistare la collezione Tarello. Sartori si impegnò personalmente ma ebbe un cortese ma netto rifiuto. Non ho idea di quale sia attualmente la situazione di questa straordinaria raccolta, così importante per Genova. Ritengo comunque non privo di significato il fatto che tutte le proposte dr cessione siano venute da collezionisti lombardi. I collezionisti genovesi sono così riservati da risultare quasi invisibili.
Conclusasi nel 1985, pochi mesi dopo l'apertura di Villa Croce, l'era Sartori, e in assenza totale di finanziamenti per campagne acquisti, l'unica concreta possibilità di costruire un patrimonio di opere d'arte contemporanea era dunque quello di mettere a frutto le solide relazioni personali, basate sulla lunga frequentazione e in qualche caso su un rapporto di amicizia, con gli artisti.
L’artista, in genere, vende per vivere ma non lavora per vendere. Il suo punto di riferimento è sempre stato e sarà sempre il museo, cui destina idealmente le sue opere migliori perché vengano interpretate, studiate, riprodotte in cataloghi, esposte al pubblico, richieste in prestito da altri musei, restaurate e soprattutto conservate per il pubblico di domani, per le "generazioni future".
Ho sempre pensato che un museo non debba necessariamente pagare per avere un'opera d'arte: la paga già con il lavoro intellettuale che i suoi studiosi le dedicano, attraverso uno scambio in natura disinteressato e di grande valore simbolico.
Naturalmente sarebbe bellissimo se il museo potesse aiutare economicamente gli artisti, ma quello che può dare intanto in termini di lavoro critico e scientifico, e più ancora, forse, in termini di apprezzamento, di intima e affettuosa comprensione e condivisione, è già molto, e gli artisti lo sanno bene. In questo senso, ogni donazione, a cominciare dalle più importanti, ha rappresentato per me una straordinaria avventura insieme estetica e umana e mi ha riservato momenti, mi si perdoni l'enfasi, di sincera commozione ed entusiasmo - forse i migliori del mio già pur piacevole lavoro.
Tale premessa, forse poco funzionariale, è necessaria per capire la metodologia con cui il Museo di Villa Croce, a quindici anni dalla sua inaugurazione. ha potuto costruire un patrimonio organico e selezionato di alcune migliaia di opere. Contrariamente a una legge non scritta, che per amore di tranquillità ha sempre avuto corso alla Direzione dei musei genovesi ("i doni si accettano sempre, al massimo si rifilano in cantina") molte proposte di donazione non sono state accettate, le opere sono state selezionate dal museo in base alla loro importanza, possibilmente in modo da costituire nuclei omogenei e rappresentativi di ogni momento della ricerca dell'artista. Solo nel caso di grandi donazioni di centinaia di opere di artisti particolarmente significativi si sono accolte opere anche "minori". Nell'accettazione o non accettazione e nella selezione delle opere ho sempre goduto, per fortuna, di piena libertà (sospetto più per disinteresse che per reale rispetto dell'autonomia scientifica): non ho mai dovuto discutere con commissioni né subire ingerenze interne ed esterne.
La responsabilità della raccolta è quindi tutta mia, nel bene e nel male. Come per ogni altro aspetto dell'attività del museo, costante è stata invece la discussione delle scelte con Sandra Solimano, sulla base di una consuetudine di collaborazione e di confronto in genere molto piacevole e comunque sempre utile; ma questo, naturalmente, è un altro discorso.
Nella formazione delle raccolte del museo mi sono dunque comportato con lo spirito e la libertà di un collezionista privato, anche se ovviamente con una sostanziale differenza: ho raccolto le opere non per me, in base al mio gusto personale, ma per gli artisti e per il pubblico, quindi non come critico o collezionista, ma come storico dell'arte, applicando cioè il giudizio critico all’individuazione della qualità dovunque essa si trovasse. Dedicarsi a una tendenza artistica può essere indispensabile per un gallerista, vantaggioso per un critico e divertente per un collezionista, ma riguarda più il commercio, lo sport o la psicopatologia che la storia dell'arte e la cultura in generale. La discutibile, anche se forse inevitabile simbiosi tra il critico e una precisa tendenza, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, è nefasta se applicata a un museo, mentre l'alternativa della commissione rappresenta non tanto un correttivo quanto una moltiplicazione di questo perverso meccanismo.
Impossibile non tornare per l'ennesima volta sul problema, e sull'accusa ricorrente, della dimensione "locale" delle raccolte, un tormentone in cui, come spesso accade, malafede e provincialismo si danno la mano. Il patrimonio di Villa Croce non è costato alla collettività praticamente nulla (anzi le ha consegnato una nuova ricchezza) ma se avessi avuto la disponibilità di miliardi avrei fatto qualcosa di più, non di sostanzialmente diverso.
È inutile commuoversi sulle proprie radici, esaltarsi dell'Europa delle Regioni e poi sentirsi menomati se non si hanno i soliti grandi nomi da esibire nel salotto buono. Ogni città con più di centomila abitanti vuole avere il suo museo metropolitano con le grandi firme, inevitabilmente fatto di opere minori, quando non di falsi o di scarti. Che se poi davvero si compera fuori, apriti cielo, fioccano subito le accuse di colonialismo e di discriminazione della ricerca locale.
A Genova la storia dell'arte "locale", almeno negli ultimi cinquant'anni, è presto raccontata: in assenza, o per debolezza, di mercato, critica, giornali, università, musei e via dicendo, cioè in assenza di una cultura cittadina diffusa e difesa dai soggetti deputati e dalle istituzioni, il "locale" può diventare "nazionale" soIo se fa le valige per Milano o Torino, o "internazionale" se varca Chiasso o meglio ancora se prende l'aereo. Salvo ritornare rapidamente "locale", dopo i riconoscimenti fuori mura o all'estero, se all'artista viene la nostalgia di casa, e qui cade in depressione, deve cambiare mestiere, o se è irriducibile continua a lavorare in manicomio oppure chiuso a chiave in una cantina dove i quattro amici vanno a trovarlo una volta all'anno. Con la certezza quindi di "non avere mercato" e il rischio di finire nella legione degli artisti bravi e magari bravissimi che la storia ha spazzato via.
Mentre con movimento inverso e speculare cascami poverissimi di arte povera, concettuale, pop, post e trans vengono rifilati ad acquirenti sprovveduti come status symbol del loro riscatto sottoculturale, mentre fuori dall'uscio o dalla bottega opere, ma anche patrimoni d'arte e di cultura sia "maggiore" che "minore", finiscono nel cassonetto della spazzatura. Perché al provincialismo puntualmente si associa il vizio italiano dell’idealismo delle graduatorie tra maggiore e minore, e allora a sparire saranno mobili, ceramiche, campionari di tessuti, scenografie, gipsoteche, biblioteche, fototeche. Che qualche volta, per fortuna, vengono comperati dagli inglesi e dagli americani, e allora li ammireremo compunti al Victoria and Albert di Londra o a Miami o a Los Angeles. Ma se i tesori raccolti restano a casa per iniziativa degli stessi inglesi o americani (come nel caso della collezione Wolfson) è subito pronta un'alta autorità culturale per restituirli alla categoria del bric-a-brac.
Le prime donazioni al museo risalgono al 1983, anteriori quindi di qualche anno alla sua apertura. La prima è quella di Corrado D'Ottavi, amico indimenticabile, che destinò tutta la sua opera al futuro museo quando si ammalò nell'estate del 1983 (sarebbe morto nel gennaio dell'anno successivo, a soli 49 anni).
L’altra, molto diversa, è quella (dovuta alla generosità della figlia dell'artista) delle opere eseguite da Giovanni Governato nell’ultimo decennio della sua vita, tra il 1941 e il 1951, testimonianza di una ricerca precorritrice, tra surrealismo astratto e protoinformale, vera cerniera tra primo e secondo Novecento.
A museo inaugurato arrivarono il dono Martini e Ronchetti (fotografie, fotomontaggi e collage di Del Marle, Domela, Florence Henry, Veronesi) e l'acquisto di un gruppo di opere della rassegna "Giappone avanguardia del futuro" (con Sartori sarebbe stato sicuramente possibile un limitato ma mirato aggiornamento sul piano internazionale); e sul piano locale il dono della gipsoteca dello scultore Guido Micheletti. Gli anni successivi (1986-87) furono segnali in negativo dalla mancata acquisizione di opere di Scanavino e di Fieschi - forse le due più gravi lacune della collezione, cui tentai inutilmente di porre rimedio negli anni successivi (l'opera dr Scanavino in catalogo è un prestito di Giampiero Reverberi, la cui collezione d'arte informale sta per lasciare Genova nell’indifferenza generale). Ma già a partire dal 1988-89 con i doni Esposto, Allosia e Galletti e il deposito Mesciulam, l'accrescimento delle collezioni riprende, per conoscere una netta accelerazione a partire dal 1990. A quell'anno risale la decisione di Sandro Cherchi di donare al museo l’intera mostra antologica in preparazione a Villa Croce per i suoi 80 anni, 275 tra sculture, dipinti, disegni e acquaforti: un'iniziativa di straordinaria intelligenza e generosità, cui i quotidiani di Genova non dedicarono neppure una riga. Dopo quella di Cherchi la donazione più importante fu, nel 1992, quella di 183 opere di Rocco Borella. Mentre Cherchi, con la sua donazione, si proponeva esplicitamente di "rappresentare tutta la (sua) vita di artista", Borella intendeva consegnare al museo, come unico possibile referente, l'esito ultimo della sua ricerca, di cui avvertiva lucidamente l’importanza e di cui né il mercato né il collezionismo privato si erano accorti. Il nucleo delle opere di Borella venne integrato in quell'occasione e negli anni successivi dai Cromemi e dai Guard-rail degli anni Sessanta e Settanta donati da Edoardo Manzoni. Dal 1992 l’incremento patrimoniale è sempre più intenso: Martino Oberto e Luisella Carretta in quell'anno, Aurelio
Caminati e Anna Oberto nel 1993, Plinio Mesciulam, Beppe Dellepiane (quasi tutta l'opera, oltre cento pezzi), Walter Di Giusto, Michelangelo Barbieri Viale nel 1994; Zappettini, Cesi Amoretti, Menegon, Sirotti, Carioti, Costa e altri nel 1995-97, Fasce e Chianese (14 dipinti e 128 acquaforti) nel 1998. A due altri doni di Edoardo Manzoni (1999) si deve il nucleo importante di 20 opere di Attilio Carreri. E nel 2000, con gli ultimi doni, le raccolte del museo si avviano a superare i tremila pezzi: conservati in deposito, naturalmente, essendo gli scarsi spazi di Villa Croce impegnati in permanenza in quell'attività di mostre che è la garanzia dell'accrescimento patrimoniale, oltre che indispensabile documentazione della ricerca artistica.
Con ciò abbiamo toccato una delle tante ragioni della necessità di questo catalogo: far conoscere la consistenza patrimoniale del museo, le cui raccolte documentano ampiamente, sa pure con inevitabili lacune, la storia dell'arte contemporanea a Genova e in Liguria, lungo l'arco dei cinquant'anni che dalla metà del secolo scorso arrivano alle soglie del nuovo millennio.
Ma vi sono ragioni anche meno evidenti. Una, non banale, è che Villa Croce, diversamente dagli altri musei, già esistenti e con un patrimonio ormai stabilizzato, non è un museo ricevuto passivamente "in gestione''. ma un museo costruito ex novo e in accrescimento permanente, sulla base di scelte critiche e di metodologie decise da me e dai miei collaboratori. Questo catalogo rappresenta dunque un'assunzione, o meglio una rivendicazione, di responsabilità.
Ma poi, purtroppo, vi sono ragioni anche più drammatiche per stabilire con un catalogo una sorta di punto fermo nella vita del museo. ragioni relative alla sicurezza e all’integrità delle raccolte.
Appaiono oggi curiosamente lontani, quasi idilliaci, i tempi in cui la minaccia più grave era rappresentata dall'assessore o dall'alto funzionano che volevano arredarsi l'ufficio, con il rischio di dispersione o di sparizione delle opere al pensionamento o alla fine del mandato. La situazione di Villa Croce, come è stato detto pubblicamente e recentemente da fonte autorevole, è "critica e difficile" - e l’ingenuo può chiedersene il perché, visto che è un museo funzionante, attivissimo, quasi "svizzero". Intanto, nell'ultima versione (ottobre 2000) del piano triennale degli investimenti del Comune di Genova i quattro miliardi iscritti a bilancio già ne1 1998 per l'ampliamento di Villa Croce (che consentirebbero l'esposizione al pubblico delle collezioni) sono stati inspiegabilmente cancellati, con ciò bloccando ogni futuro sviluppo del museo. Ma al di Ià dell’incerto scenario dell'arte contemporanea, sui musei genovesi in genere corrono davvero nubi di tempesta: voci e interviste - non importa se vere o false, perché comunque delegittimanti - di collezioni che cambiano museo, di musei che cambiano collezioni, che si accorpano, che migrano verso il centro (o viceversa), si chiudono, si privatizzano, si istituzionalizzano, si "esternalizzano" (i furbi inventano i neologismi,
e gli stupidi ne fanno dei tic linguistici), si vendono, si svendono, si trasformano in supermercati, parchi giochi, luna park, poli dell'avventura (!), poli ludici, virtuali, interattivi. Il tutto, ovviamente, nella sostanziale indifferenza nei confronti di chi ci lavora, dagli studiosi agli uscieri, e con il bel risultato, già da subito, di spaventare i privati e mandare in fumo lasciti e donazioni.
E del resto delle opere d'arte, in questa ventata di modernizzazione e di allegra rottura degli schemi, si prospetta persino la vendita, tenendo i vincoli in conto di carta straccia, com'è antica consuetudine nell'Italia patria del diritto. Idee che una volta non si aveva il coraggio di esprimere neppure in camera da letto vengono ora sbandierate sui giornali e in tavole rotonde e latte proprie dai politici più inclini a cavalcare la tigre della modernità.
E tutto ciò in nome dell'economia, della razionalizzazione, della produttività; e, sul piano del consenso, della "visibilità", della "pubblica fruizione", del "popolare" e dello "spettacolare" come senso ultimo della democrazia.
Che poi, al di là della tentazione un po' aleatoria di trarne consensi o di raggiungere il mitico pareggio di bilancio, tanta attenzione nei confronti dei musei, in fondo cosi innocui e marginali, non si spiega se non in considerazione del loro valore simbolico, che resta altissimo, come deposito di culture che si avvertono tanto più estranee e nemiche quanto più sono raffinate: e quindi in grado di scatenare i soliti complessi di inferiorità culturale, cioè sociale, specie nei momenti e nei luoghi di veloce ricambio sociale, come negli ultimi decenni in Italia, senza neppure un regolamentare passaggio di consegne tra le vecchie élite e il nuovo "pubblico" (dei cui "bisogni", ovviamente i politici si fanno "interpreti").
Altro che cataloghi scientifici, dunque, e inventari e campagne fotografiche e restauri e acquisti! Verrebbe voglia di seguire l'esempio, lontanissimo e attualissimo, di quei sacerdoti del tempio Capitolino di Brescia, che all'arrivo dei barbari nascosero i tesori del tempio - la Vittoria alata, i vetri preziosi, i ritratti in bronzo dorato degli Imperatori – nell’intercapedine tra l'edificio e il Colle Cidneo: consentendone cosi la "fruizione" alle "generazioni future" (e agli assessori di farci le mostre). Ma risulta anche che i cosiddetti barbari non erano poi cosi incivili, anzi proprio a Brescia, a due passi dagli scavi romani, una mostra recente ha dimostrato che i Longobardi erano rispettosissimi della tradizione, che volevano conservare e rinverdire, mentre, negli stessi secoli, gli iconoclasti erano gli imperatori "romani" di Bisanzio (cosi come adesso, per via dei soliti corsi e ricorsi, i marocchini, i senegalesi e i pakistani e in genere gli ex colonizzati da inglesi e francesi, sono colti, poliglotti, beneducati e quindi sovente più civili dei nostri connazionali).
|