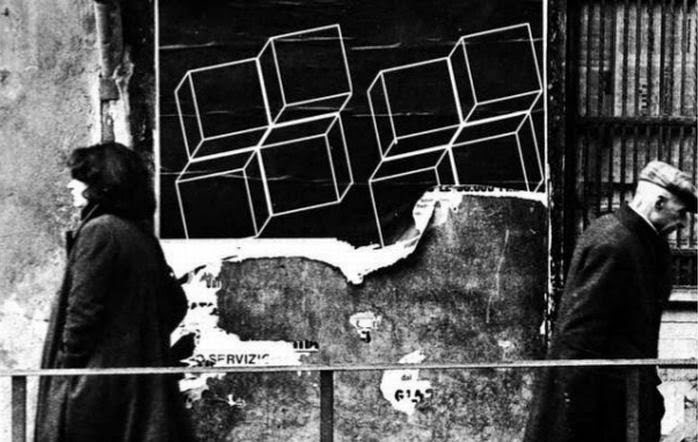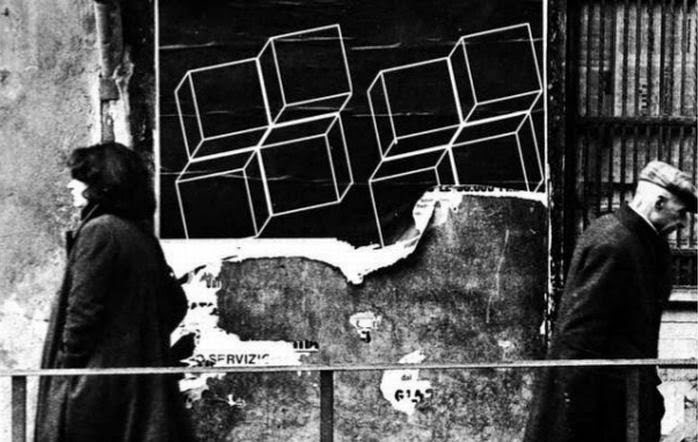|
GENOVA: LA CULTURA DI UNA POLITICA #2
DALLA POLITICA DELLA CULTURA ALLA CULTURA DELLA POLITICA
Guido Giubbini
Di un intervento culturale si può indicare non tanto la “correttezza” oggettiva, la conformità rispetto a valori dati o a modelli di riferimento, ma la maggiore o minore capacità di adattamento rispetto a situazioni storicamente determinate. Tale capacità non si identifica con l’uso strumentale della cultura, anzi ne rappresenta il più radicale superamento: essa implica uno sforzo costante di analisi e un distacco altrettanto grande dagli “interessi” quanto dagli “ideali”. Da questo punto di vista, ogni calcolo politico sulla cultura, come ricerca di potere attraverso il travestimento ideologico, appare soprattutto come una forma di autoinganno.
A questo ordine di problemi si può ricondurre, pur nei suoi limiti di spazio e di tempo, l’esperienza pubblica nel settore dell’arte contemporanea condotta a partire dal ’79 dal Comune di Genova. Mi sembra che il senso di questa attività non consista tanto nell’aver proposto iniziative in qualche modo esemplari per la “qualità” delle scelte o per la “coerenza” nei confronti di un disegno di politica culturale (anche se questa è stata una preoccupazione effettiva), ma come primo momento di orientamento e di analisi sui meccanismi della produzione e del consumo dell’arte e più in generale sulle tecniche di legittimazione del potere attraverso gli strumenti dell’intervento culturale. E questo non perché qualità e coerenza siano venute meno, ma perché si sono rivelate inadeguate come criteri di giudizio.
Il punto di partenza, certamente, è stato un progetto politico e in particolare l’ipotesi di una presenza indipendente delle strutture pubbliche nella gestione della produzione artistica: un’ipotesi i cui limiti (il moralismo, l’illuminismo) non devono far dimenticare che essa è servita a indebolire vecchie “mafie”, ad accentuare la crisi complessiva dell’organizzazione tradizionale della cultura, ad aprire spazi limitati ma reali di espressione e di ricerca.
Nel campo della produzione artistica, tuttavia, quello che doveva essere un tentativo di affrancare gli artisti dai condizionamenti del mercato e di collegarli con le esigenze della collettività, attraverso la mediazione dell’ente pubblico e del museo, ha dovuto fare i conti con la tendenza, ben più definita e articolata, del mercato dell’arte a darsi un’articolazione razionale attraverso un rapporto più stretto fra intervento pubblico e intervento privato.
In Italia, l’assenza o la debolezza delle strutture pubbliche e il carattere prevalentemente privato dell’organizzazione del mercato artistico sembravano autorizzare l’elaborazione di un progetto di intervento pubblico intorno al quale raccogliere interessi più larghi che non fossero quelli della committenza tradizionale e di ristrette categorie di intermediari.
Ma questa ipotesi, che sembrava favorita dalla situazione politica degli anni settanta, ha stentato a concretizzarsi, e ora sta venendo avanti una variante corporativa e accentratrice di quell’intreccio fra pubblico e privato che appare ormai indispensabile per una gestione razionale del mercato: quella che vede una parte della critica pianificare larghi settori del mercato nazionale con il supporto finanziario e organizzativo degli assessorati alla cultura.
Nessuno, ovviamente, si fa illusioni sul fatto che all’interno di un sistema di mercato gli interventi dell’ente pubblico possano sfuggire ai suoi meccanismi. Per esorcizzare questa che viene sentita come una colpa (quale amministratore potrebbe riconoscere senza imbarazzo di essere un procuratore d’affari?) l’ente pubblico rivendica a sé la funzione culturale, cioè una sorta di vocazione per il riconoscimento e la difesa della “qualità” della ricerca artistica e per la creazione delle condizioni che favoriscano l’informazione.
Le ragioni utilitaristiche del mercato vengono dissociate così dalle ragioni culturali dell’ente pubblico e del museo. Se mai si chiede al mercato di fare anche cultura, e al museo di “moralizzare” dall’esterno, con la sua stessa presenza, il mercato. Ma è un alibi fragile.
Intanto, questa “garanzia culturale” è proprio ciò di cui ha bisogno il mercato per avere credibilità e continuare a svilupparsi. Garanzia culturale significa infatti garanzia di investimento sicuro – che è esattamente ciò che persegue un mercato maturo. Quanto all’informazione, se è vista astrattamente e illuministicamente come un fatto di diffusione della cultura, del buon gusto e dell’amore per l’arte, cioè non è collegata a un progetto di modificazione dei meccanismi ideologici e economici di produzione e di consumo, rischia soltanto di accrescere le frustrazioni. L’informazione, infatti, ha un senso solo in quanto è destinata a un pubblico di possibili consumatori.
L’obiettivo di sensibilizzare all’arte un pubblico che non ha la possibilità di acquistarla non è credibile, almeno finché hanno corso certi modelli economici e culturali, che sono poi quelli della proprietà privata dell’arte come forma di investimento o come simbolo di stato. In realtà la scolarizzazione di massa e soprattutto l’influenza dei media, provocando un’acculturazione senza precedenti, hanno messo in crisi quei modelli, del tutto indipendentemente dal museo. A questo non resta che adeguarsi e trovare una nuova funzione: quella di offrire, attraverso il consumo sociale dell’arte, un’alternativa all’allargamento della proprietà privata individuale, di rispondere alla domanda sociale attraverso un consumo senza proprietà.
Perciò al modello del consumo individuale d’élite si sta affiancando quello della “fruizione pubblica” dell’arte, cioè soprattutto della fruizione, da parte di un pubblico tendenzialmente di massa, delle opere d’arte esposte e conservate nei musei.
Questo modello comporta non solo il controllo del consumo attraverso l’uso degli strumenti di informazione e di persuasione, ma anche un controllo della produzione attraverso una sorta di mercato pubblico dell’arte. Tale controllo può esplicarsi ad esempio attraverso un rapporto diretto tra gli artisti e il museo, nel senso che gli artisti svolgono la loro ricerca in collegamento col museo o addirittura in musei-laboratorio, sono finanziati in forme diverse dal museo e selezionati da una critica prevalentemente o interamente inserita nelle strutture pubbliche.
Tutto ciò, evidentemente, pone ai nuovi amministratori problemi di non facile soluzione. Per loro, se appena riflettono sui meccanismi del mercato dell’arte, le attenzioni interessate di cui, da qualche tempo, è diventato oggetto l’ente pubblico non possono essere assolutamente motivo di soddisfazione. Potrebbero chiedersi, non senza ragione, che senso abbia un dispendio così notevole di energie e di mezzi pubblici per sostenere prodotti, come quelli artistici, così sofisticati, destinati in partenza a un consumo ristrettissimo, del tutto inadeguati a innalzare la qualità media dell’esistenza e vantaggiosi soltanto per i collezionisti e per i loro intermediari. Né, d’altro canto, li può tranquillizzare, se non nella prospettiva del consenso immediato, il fenomeno della partecipazione anche vistosa del pubblico alle mostre o alle altre manifestazioni culturali, in quanto si tratta per lo più di una partecipazione rituale, consumistica, che nasce più dalla ricerca di alternative di evasione, dall’uso pubblicitario dell’informazione, dalla ricerca di gratificazioni culturali e sociali che da un atteggiamento critico e da un diverso uso delle strutture educative. Né può essere motivo di conforto, almeno per chi intenda portare avanti un progetto di respiro più largo che non quello della vecchia gestione strumentale della cultura, la constatazione che questa attività serve a legittimare l’immagine dell’ente pubblico.
In realtà gli interventi dell’ente pubblico sono costretti a seguire, al di là delle buone intenzioni, copioni già stabiliti. Le mostre d’arte organizzate dai musei pubblici non sono dissimili da quelle delle gallerie private: come queste si rivolgono a un ambiente ristretto e presentano il prodotto artistico come merce di lusso di cui garantiscono la qualità, e se ne distinguono perché non traggono da queste operazioni vantaggi economici ma solo legittimazione ideologica. Quando il museo si propone (anche con successo) di fare delle mostre d’arte una meta della fruizione pubblica di massa, deve ricorrere agli stessi espedienti pubblicitari e allo stesso tipo di sollecitazioni a cui ricorre l’industria culturale. Nell’uno come nell’altro caso, tipi diversi di pubblico, motivati gli uni da interessi immediati e gli altri dalla ricerca di modelli di identificazione, sono accomunati dalla stessa ritualità e dalla stessa indifferenza per il “valore artistico” che entrambi concordano nel voler esaltare e difendere.
La constatazione del carattere subordinato dell’intervento pubblico rispetto al mercato deve far riflettere sulle reali possibilità di modificare certi meccanismi, e comunque sulle metodologie da seguire per modificarli. L’incertezza riguarda ormai la possibilità stessa di recuperare nella loro dimensione originaria i diversi ruoli intellettuali, la loro “moralità” il loro statuto specifico, teorico e sociale. Gli artisti che credono nel ruolo dell’arte, così come i critici che si propongono di giudicare gli “autentici” valori, hanno l’aria un po’ irreale di chi recita una parte. Né più credibile sembra il politico quando, proponendosi di controllare o di eludere i meccanismi del mercato, recupera la cultura come “servizio sociale” o cerca alibi nei riti della fruizione pubblica.
Nel gioco sempre più incontrollabile dei modelli le buone intenzioni si confondono con il calcolo e l’istanza morale con la riproposta delle vecchie figure e di ruoli ormai screditati. L’unica prospettiva sembra dunque quella di trarre partito dalla crisi sempre più profonda dei valori e dalla confusione dei modelli non per richiamarsi a nuovi valori o per riproporre modelli, ma per respingerne esplicitamente la funzione di alibi.
Tra i valori culturali in crisi vi sono certamente il ruolo dell’artista, così come le antitesi classiche tra arte e non arte, cultura alta e cultura divulgata, centro e periferia, e quindi i modi stessi del rapporto tra potere politico-culturale e pubblico di massa. All’artista, che nel corso degli ultimi venti anni ha respinto consapevolmente i mezzi artistici, non resta altro che condurre alle estreme conseguenze queste premesse, negando validità al concetto stesso di arte. Quanto ai concetti di provincialismo, visto come non-valore, di didattica come sotto-scienza, di arte e non arte e così via, essi vanno ribaltati non per creare dei contro-valori, ma per negare a queste antitesi ogni valore.
Di conseguenza anche il rapporto con il pubblico va visto nella sua dimensione altra, irriducibile al concetto di divulgazione, e invece come frutto dell’interazione fra culture sommerse ed effetti imprevedibili, non di rado contraddittori, dei modelli diffusi dalla industria culturale di massa e dalla pubblicità.
Per questi motivi non credo abbia alcun senso definire “provinciale” la scelta di svolgere un lavoro sistematico sulle situazioni locali, così come è stato fatto a Genova. Tale scelta non muoveva soltanto dalla convinzione, apparentemente ovvia, che una situazione provinciale diventa avanzata solo partendo dall’interno di essa; o dalla necessità di ricomporre un tessuto culturale disgregato stabilendo rapporti diretti e continuativi tra operatori interni ed esterni all’istituzione; o dalla constatazione della molteplicità e ricchezza delle situazioni locali, vasto entroterra di differenza che ha mantenuto in vita potenzialità insospettate e offre quindi occasioni di libertà e un terreno privilegiato di sperimentazione; ma, innanzitutto, dalla constatazione che il concetto stesso di provincialismo è parte di un gioco il cui obiettivo è quello di trasformare in periferia indifferenziata tutto ciò che è al di fuori delle sedi decisionali del mercato.
Una città, un paese, un territorio diventano provincia ogni volta che esiste un “centro” che deve smerciare i suoi prodotti. Come il concetto di nazione (o di civiltà occidentale, e così via) nascono per definire un mercato e si modificano non appena mutano le prospettive geografiche di espansione o di contrazione del mercato, così i concetti di centro e periferia, di metropoli e di provincia non rappresentano valori stabili ma si trasformano rapidamente sino a scambiarsi con il loro contrario non appena muta un certo modello di sviluppo economico.
Né, d’altra parte, si tratta di mitizzare la provincia per i suoi valori di genuinità e diversità, da contrapporre al centro che colonizza, emargina e livella le differenze. Sono i concetti stessi di valore e non valore, in quanto intercambiabili a seconda delle situazioni storiche, che appaiono sempre meno attendibili.
La scelta di collaborare con gli artisti è stata anch’essa una scelta difficile, in quanto inadatta a dare frutti immediati in termini di consenso. Non li dà al livello del pubblico di massa (influenzato soprattutto dalle iniziative di prestigio) e non li dà al livello degli stessi operatori, abituati da sempre, e non a torto, a considerare l’istituzione come la controparte di una contrattazione di tipo sindacale e più in generale ogni potere, sia pubblico che privato, come un nemico naturale, preoccupato soltanto di neutralizzare gli elementi più vivi e conflittuali della propria ricerca per farne un uso grettamente economico o vacuamente decorativo. La crisi attuale, tuttavia, è talmente profonda da essere ormai dentro le istituzioni, e tanto più dove le istituzioni si trovano a rifletter spinte eccentriche e de-totalizzanti, come nelle amministrazioni locali, insieme prodotto e terreno di coltura di una crisi che investe in eguale misura amministratori e intellettuali. Perciò il rapporto con gli artisti non è più soltanto il frutto di un calcolo di alleanza, ma il riflesso di una più generale insoddisfazione per i ruoli intellettuali, per le loro suddivisioni e la loro collocazione nelle sedi deputate.
Che poi il rapporto tra l’ente pubblico e gli artisti non possa essere lo stesso che con i critici, non dipende dal fatto che si mitizzi una improbabile sintesi tra arte e politica al di fuori delle mediazioni del mercato, ma dalla diversa posizione che queste figure hanno nei confronti del mercato.
È certamente vero che gli artisti, a causa dell’individualismo che li ha sempre caratterizzati e ne ha reso così spesso velleitario il comportamento, tendono a sopravvalutare la loro autonomia e il carattere trasgressivo della loro arte.
Ancora oggi, tuttavia, non si sottolinea abbastanza che nell’ambito delle neo-avanguardie l’assunzione di materiali e comportamenti non artistici, l’integrazione con i media, il porsi esplicito dell’artista come soggetto economico hanno rappresentato la sfida più alta sinora portata dall’avanguardia al mercato capitalistico dell’arte. Il radicalismo di questo atteggiamento ha determinato nel mercato una risposta proporzionale: la negazione stessa del valore è stata assunta come il massimo del valore attraverso la parola del critico, l’avanguardia, sottoposta al dispositivo delle mode, è diventata norma e retorica, la produzione è stata controllata in partenza e pianificata con metodi pressoché industriali, il museo è stato cooptato come strumento di integrazione attraverso l’alibi della fruizione collettiva-. Di più, il mercato è riuscito a dimostrare che il massimo della negazione del valore economico dell’opera d’arte può coincidere con il massimo del suo valore economico reale e quindi con il massimo della sua compromissione. Con ciò, tuttavia, l’avanguardia è riuscita a spostare il confronto su un terreno più avanzato, in cui il valore artistico e valore economico, valore d’uso e valore di scambio si confondono, e una crisi complessiva dei valori mina ogni prospettiva di riappacificazione.
Il critico ha visto enfatizzato il suo ruolo nel momento in cui, pur conservando l’originaria funzione intellettuale, si è’ legato più strettamente al mercato dell’arte, a cui ha garantito la trasformazione in valore economico non già del valore artistico, così come era sempre avvenuto, ma della sua negazione, così come si è reso necessario dopo l’esperienza delle avanguardie storiche e soprattutto delle neo-avanguardie. L’oscurità del linguaggio della critica d’arte non è dovuta soltanto, come si crede, alla divisione della società e alla moltiplicazione dei codici connessa al definirsi delle discipline, ma innanzitutto alla necessità, da parte del critico, di fondare il proprio giudizio non sull’analisi della qualità ma sul carisma della parola. A questo punto, come è noto, il critico si è trasformato da investigatore di talenti e di qualità artistica in pianificatore della ricerca e della produzione e in creatore di valori artistici – quindi artista e creatore egli stesso.
Tuttavia l’incertezza e la crisi dei valori che il critico ha contribuito a determinare in questa nuova veste ne hanno rapidamente usurato l’immagine. Egli è ora costretto a tentare un recupero moralistico del suo statuto sociale originario attraverso una sorta di autocritica che ne rimuova l’aspetto mercantile e ne valorizzi la funzione scientifica e didattica.
Perciò il critico cerca ora il suo interlocutore non più nell’ambito del potere economico, ma di quello politico, e in particolare nell’ente pubblico inteso come interprete dei bisogni della collettività. C’è tuttavia da domandarsi se questa operazione, per quanto bene intenzionata, sia davvero efficace, se cioè il fatto di offrire al critico, attraverso il collegamento con l’ente pubblico, un alibi nei miti della fruizione collettiva e del consumo sociale dell’arte, lungi dal restituire credibilità e dignità a un ruolo semplicemente degradato o compromesso, non significhi tenere artificialmente in vita una figura che non può sopravvivere alla disgregazione che essa stessa ha provocato. Né d’altra parte avrebbe alcun senso trasferire all’artista la funzione critica nel momento in cui essa si sta dissolvendo sul piano più generale della cultura. La tendenza propria dell’avanguardia a rivendicare all’artista la funzione critica ha rappresentato e rappresenta un fenomeno importante e significativo, come risposta all’arbitrarietà delle scelte dei critici, ma essa, così come ogni analisi del ruolo dell’artista che non metta in discussione questo ruolo, si pone al di qua del problema reale, che è quello della crisi del giudizio di valore in una società in cui è in crisi il principio di valore.
Queste considerazioni hanno un carattere del tutto provvisorio; esse rappresentano soltanto un primo bilancio su un’esperienza d’intervento pubblico che ha avuto il vantaggio, rispetto ad altre, di essere stata relativamente immune dai condizionamenti imposti dalle altre strutture culturali (a Genova particolarmente deboli) e dalle preoccupazioni pubblicitarie del potere politico, e quindi di essersi misurata direttamente con i meccanismi – e con i condizionamenti – più generali. Molto schematicamente, se da un lato esce confermata l’opportunità di alcune scelte iniziali (la collaborazione con gli operatori, il rifiuto di qualsiasi delega alle strutture culturali ufficiali, l’indifferenza per l’uso ideologico dell’operazione artistica, la convinzione che la crisi dei ruoli e dei modelli è penetrata profondamente nelle stesse istituzioni e su questo terreno va analizzata, il sospetto che il rapporto col pubblico debba essere pensato in una dimensione ben più complessa di quella offerta dagli abituali schemi pedagogici), d’altra parte si allontanano o sfumano i contorni di più ampi e “costruttivi” disegni, senza per questo che venga meno, anzi risultandone confermata, la necessità di un’alternativa radicale. I dubbi più consistenti riguardano la possibilità di fare dell’arte un servizio sociale garantito dalla correttezza e dal disinteresse dell’ente pubblico; il progetto di restituire all’operatore artistico una socialità positiva, sia nella forma tradizionale della professionalità che in quella più recente dell’animazione collettiva; la speranza in una soluzione dialettica del conflitto tra arte pura e arte applicata attraverso la creazione di un nuovo stile omogeneo e unificante; infine la fiducia in un’azione didattica volta a rendere l’arte non solo comprensibile a tutti ma realizzabile da tutti.
Tanto meno, dunque, a queste conclusioni può essere chiesta una coerenza con l’attività concretamente svolta, da cui esse traggono soltanto materia d’analisi. È stato sottolineato efficacemente che il problema dell’arte coinvolge non solo le opere e le scelte critiche che le riguardano, ma anche i modi della sua veicolazione e l’immagine stessa che si danno le strutture museali. Al di là del problema dell’arte e della sua comunicazione, esiste tuttavia anche una realtà politico-culturale le cui finalità e i cui procedimenti sono in genere rigorosamente occultati. Anche mettendo da parte le esigenze dello storico, che sa bene quanto sia ingenua l’affermazione che “alla fine quello che conta è la qualità”, l’operazione ideologica attraversa oggi una crisi così profonda che qualsiasi disegno politico-culturale ha ben poco da perdere a esibire dispositivi e motivazioni.
(dal volume-catalogo Genova: la cultura di una politica. Storia per immagini di cinque anni di lavoro culturale nella città, a cura di Mario Guaraldi, Electa, Milano 1981)
|